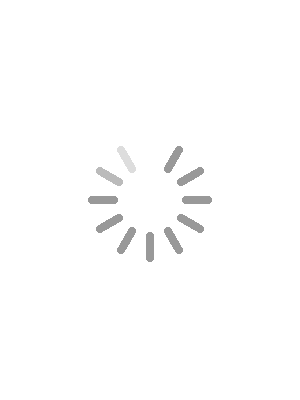Una Salute Mentale a trazione forense?
Una delle questioni classicamente più dibattute in psichiatria è: dobbiamo avere paura dei pazienti? Sono pericolosi? E, in caso affermativo, gli psichiatri sono tenuti per legge a contenerne la pericolosità?
Purtroppo le risposte “ufficiali” a queste domande continuano a essere contraddittorie e generano non poca incertezza. Prendiamo la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 76/2025, dello scorso 30 maggio (1). Se ne è parlato molto, anche in questo giornale, perché ha esteso le garanzie per i pazienti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio ospedaliero (TSO) disponendo che siano auditi direttamente dal giudice tutelare prima della convalida dell’ordinanza di ricovero.
Molto meno si è parlato di un altro risvolto della stessa sentenza, la quale ha ribadito uno dei principi cardine della legge 180 e cioè che il TSO non può mai essere motivato da ragioni di difesa sociale, quindi di pericolosità del paziente, ma solo da esigenze di cura. Ha dunque confermato un principio “basagliano” che è tuttora un unicum a livello internazionale, perché quasi ovunque nel mondo la pericolosità a sé e agli altri motiva i trattamenti psichiatrici coercitivi.
Al tempo stesso, però, i giudici costituzionali hanno ricordato che nell’ordinamento italiano esistono “altri istituti che presuppongono la pericolosità sociale della persona affetta da infermità mentale e che sono finalizzati anche alla protezione dell’incolumità e di diritti costituzionali di terzi, quali le misure di sicurezza”.
In questa sottile distinzione giuridica sta la macroscopica contraddizione in cui sono costretti a muoversi gli psichiatri nel nostro Paese. Le misure di sicurezza, un tempo fenomeno relativamente raro, sono esplose negli ultimi anni, soprattutto dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. E’ sempre più frequente che i pazienti dei Dipartimenti di salute mentale siano oggetto di provvedimenti giudiziari, poiché hanno commesso qualche reato, grande o piccolo, e sono stati giudicati non imputabili per incapacità di intendere e volere. Ne consegue un giudizio di “pericolosità sociale psichiatrica” demandato a un perito, il quale valuta sulla base di una serie di criteri che la dottrina psichiatrico-forense descrive con chiarezza.
Se ci riferiamo al trattato del prof. Ugo Fornari (2) tra i più autorevoli e influenti, vediamo che si tratta di criteri molto familiari allo psichiatra clinico: risultano ad alta pericolosità e bisognosi di elevata protezione e controllo i soggetti con le seguenti caratteristiche: sintomatologia acuta, deliri, atteggiamento non collaborativo e “non consapevole”, rifiuto o scarsa risposta alle cure, tendenza all’impulsività, difficoltà ad autoregolarsi. Sono sostanzialmente le condizioni che presentano i pazienti più gravi con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Sono anche, all’ingrosso, i criteri clinici che giustificano il trattamento sanitario obbligatorio.
E’ chiaro che ci stiamo confrontando con un gigantesco paradosso: la stessa, identica situazione clinica ci impone di agire in senso custodiale, come controllori e garanti della pericolosità sociale, se il paziente ha già commesso un reato; e in senso unica mente curativo se non lo ha "ancora" commesso.
Evidentemente il paradosso non può reggere al confronto con la realtà. Se la dottrina psichiatrico-forense oggi dominante ha stabilito che un paziente grave con sintomatologia standard (delirante, oppositivo, "inconsapevole", tendente all'agito) è altamente pericoloso e la psichiatria deve metterlo in condizioni di non nuocere, il principio (e la posizione di garanzia che ne deriva) non potrà che applicarsi anche in senso preventivo.
Diverse sentenze della magistratura sono già andate in quella direzione. Immaginiamo un paziente che abbia tutti i criteri psichiatrico-forensi di potenziale pericolosità e che un Centro di salute mentale, in accordo con i vecchi principi della psichiatria territoriale, stia cercando di avvicinare gradualmente, anche se non accetta farmaci, vedendolo tutti i giorni, andando a domicilio, ecc. Mettiamo che, nel frattempo, aggredisca un vicino di casa. Questo vicino, non avrà forse tutte le ragioni per citare in giudizio gli psichiatri del Csm, visto che non hanno "messo in sicurezza" il paziente, nonostante sussistessero tutte le condizioni di pericolosità sociale psichiatrica? Il fatto che non fosse già sottoposto a una misura di sicurezza non sembrerebbe un'esimente molto valida, neanche dal punto di vista etico.
È chiaro che questa contraddizione gigantesca dovrà essere sanata. E vediamo solo due strade possibili. La prima strada è eliminare il concetto stesso di pericolosità sociale psichiatrica, applicando anche ai pazienti autori di reato i principi della legge 180, ribaditi dalla Consulta (la psichiatria cura e basta, non si occupa di pericolosità); in tal caso la pericolosità sociale sarà valutata solo dal giudice, come avviene per ogni cittadino. E’ la via proposta dal Coordinamento degli psichiatri toscani (3), che propone di rivedere radicalmente in concetto di non imputabilità, per rifiutare l’idea che la pericolosità di un malato di mente sia un puro fenomeno sanitario, da delegare in toto alla psichiatria.
La seconda strada è opposta: togliere di mezzo una volta per tutte i principi della legge 180 in modo che anche in Italia la pericolosità per sé e per gli altri torni a essere ufficialmente il principale criterio per l'azione ordinaria degli psichiatri, a partire dai trattamenti sanitari obbligatori. Sembra essere l’orientamento che traspare dalla bozza di Piano d’Azioni Nazionale per la Salute Mentale (4) presentata nei giorni scorsi, che contiene due ponderosi capitoli in cui la pericolosità dei pazienti viene presentata come un fattore strutturale e intrinseco della malattia mentale, e non si mette affatto in discussione che risolverla in sostanziale autonomia (tutt’al più col supporto “gestionale” episodico delle forze dell’ordine) sia un dovere istituzionale della psichiatria. E si propongono misure coerenti, come l’aumento dei posti letto nelle strutture residenziali per misure di sicurezza, detentive e non, e l’organizzazione dei luoghi di cura psichiatrica secondo il criterio della sicurezza, intesa sostanzialmente come contenimento di pericolosità a se e agli altri.
In effetti, se dovesse prevalere questa seconda strada e si decidesse di archiviare l’esperienza basagliana per ripristinare senza ambiguità l’orientamento “pericolosista” che imperava prima del 1978, una riorganizzazione conseguente dei servizi sarebbe doverosa. Perché tornare a una sorta di nuovo manicomialismo a trazione forense senza manicomi (cioè senza strutture pensate prioritariamente per custodire pazienti considerati irresponsabili e pericolosi) comporterebbe davvero troppi rischi. Inaccettabili anche per noi psichiatri più nostalgici del passato riformatore e, come direbbe qualche collega, più ideologizzati.
Enrico Di Croce
Psichiatra, libero professionista, Torino