Tassa Rifiuti
Avevo letto che qualcuno s ...
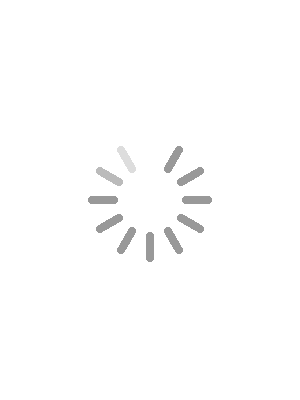
 Quanti sono davvero i trattamenti sanitari obbligatori in Italia? Molti di più di quelli che leggiamo nei dati ufficiali. La Società italiana di epidemiologia psichiatrica parla chiaro: i Tso reali sarebbero circa il doppio di quelli registrati dal Ministero della Salute. Nel 2023 si parla di 2,3 casi ogni diecimila abitanti, ma i documenti ufficiali ne riportano solo la metà. A Torino, per esempio, tra il 2017 e il 2024 ne sono stati contati 1.666. Possibile che i numeri non tornino così tanto?
Il punto è che il sistema di rilevazione è pieno di falle. Le schede ospedaliere, base delle statistiche ministeriali, non vengono aggiornate quando un Tso diventa volontario dopo pochi giorni. E succede spesso. Oppure, nei ricoveri d’urgenza, il provvedimento del sindaco arriva dopo, e l’informazione si perde per strada. In sostanza, una parte importante dei Tso resta fuori dai radar.
Ma non si tratta solo di numeri. Un Tso non è una procedura qualsiasi: significa limitare la libertà personale di qualcuno per motivi di salute. È un atto forte, che va maneggiato con cura. E allora una domanda sorge spontanea: come possiamo migliorare le cose se non sappiamo nemmeno quante volte succede davvero?
Da qui l’idea, proposta dal sociologo Michele Miravalle dell’Università di Torino, di creare osservatori locali sui Tso. Strumenti che servirebbero a capire dove, quanto e perché si ricorre a queste misure. Non solo per contare, ma per individuare i quartieri più fragili, capire se il disagio mentale si intreccia con la povertà, e potenziare le reti di sostegno.
C’è poi un aspetto ancora più delicato: la contenzione meccanica, cioè legare fisicamente il paziente. Dovrebbe essere un’eccezione, ma accade in circa un Tso su cinque. E secondo lo psichiatra Fabrizio Starace, spesso dipende più dalla mentalità del personale che da una reale necessità clinica. Qui la domanda è inevitabile: stiamo curando o stiamo solo controllando?
Una buona notizia però c’è. Con la sentenza n.76 del 2025, la Corte costituzionale ha deciso che chi subisce un Tso deve essere ascoltato dal giudice tutelare prima della convalida. Un passo avanti, almeno sulla carta. Peccato che spesso queste audizioni avvengano in videoconferenza, magari con un paziente sedato o non pienamente cosciente. A quel punto, che senso ha parlare di garanzia dei diritti?
Alla fine, il quadro che emerge è chiaro: i Tso in Italia sono più frequenti di quanto immaginiamo e spesso poco monitorati. Forse è il momento di fare più domande e meno conti approssimativi. Perché dietro ogni numero c’è una persona, e capire davvero cosa succede può fare la differenza tra una cura e una forzatura.
https://comitatostudisanita.wordpress.com/
https://fai.informazione.news/u/comitatosalutepsiche
Quanti sono davvero i trattamenti sanitari obbligatori in Italia? Molti di più di quelli che leggiamo nei dati ufficiali. La Società italiana di epidemiologia psichiatrica parla chiaro: i Tso reali sarebbero circa il doppio di quelli registrati dal Ministero della Salute. Nel 2023 si parla di 2,3 casi ogni diecimila abitanti, ma i documenti ufficiali ne riportano solo la metà. A Torino, per esempio, tra il 2017 e il 2024 ne sono stati contati 1.666. Possibile che i numeri non tornino così tanto?
Il punto è che il sistema di rilevazione è pieno di falle. Le schede ospedaliere, base delle statistiche ministeriali, non vengono aggiornate quando un Tso diventa volontario dopo pochi giorni. E succede spesso. Oppure, nei ricoveri d’urgenza, il provvedimento del sindaco arriva dopo, e l’informazione si perde per strada. In sostanza, una parte importante dei Tso resta fuori dai radar.
Ma non si tratta solo di numeri. Un Tso non è una procedura qualsiasi: significa limitare la libertà personale di qualcuno per motivi di salute. È un atto forte, che va maneggiato con cura. E allora una domanda sorge spontanea: come possiamo migliorare le cose se non sappiamo nemmeno quante volte succede davvero?
Da qui l’idea, proposta dal sociologo Michele Miravalle dell’Università di Torino, di creare osservatori locali sui Tso. Strumenti che servirebbero a capire dove, quanto e perché si ricorre a queste misure. Non solo per contare, ma per individuare i quartieri più fragili, capire se il disagio mentale si intreccia con la povertà, e potenziare le reti di sostegno.
C’è poi un aspetto ancora più delicato: la contenzione meccanica, cioè legare fisicamente il paziente. Dovrebbe essere un’eccezione, ma accade in circa un Tso su cinque. E secondo lo psichiatra Fabrizio Starace, spesso dipende più dalla mentalità del personale che da una reale necessità clinica. Qui la domanda è inevitabile: stiamo curando o stiamo solo controllando?
Una buona notizia però c’è. Con la sentenza n.76 del 2025, la Corte costituzionale ha deciso che chi subisce un Tso deve essere ascoltato dal giudice tutelare prima della convalida. Un passo avanti, almeno sulla carta. Peccato che spesso queste audizioni avvengano in videoconferenza, magari con un paziente sedato o non pienamente cosciente. A quel punto, che senso ha parlare di garanzia dei diritti?
Alla fine, il quadro che emerge è chiaro: i Tso in Italia sono più frequenti di quanto immaginiamo e spesso poco monitorati. Forse è il momento di fare più domande e meno conti approssimativi. Perché dietro ogni numero c’è una persona, e capire davvero cosa succede può fare la differenza tra una cura e una forzatura.
https://comitatostudisanita.wordpress.com/
https://fai.informazione.news/u/comitatosalutepsiche 
Corte Costituzionale, sentenza 30.05.25 n.76
Illegittime le norme della legge sul trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera laddove non prevedono la previa notifica del provvedimento sindacale, nonché l’audizione da parte del giudice tutelare presso il luogo in cui la persona si trova, quali presidi giurisdizionali minimi, parte dello statuto costituzionale della libertà personale.
Rif. Leg. Artt. 33, 34 e 35 Legge 23 dicembre 1978 n. 833
TSO – diritto alla salute – diritto fondamentale dell’individuo – giusto processo - contradditorio
Per il giudice rimettente - la Corte di cassazione - la normativa vigente mostra che il sindaco e il giudice tutelare comunicano tra loro, ma nessuno dei due comunica con il paziente, non essendo prevista né la comunicazione del provvedimento sindacale, né la notificazione del successivo decreto di convalida.
Del pari l’eventuale impugnazione del decreto avverrebbe «al buio», non essendo la persona resa partecipe degli atti a monte della convalida; la mancata audizione della persona da parte del giudice tutelare prima della convalida o anche successivamente rende il controllo giuridsizionale meramente formale quando non autoreferenziale.

Il diritto al contraddittorio del paziente psichiatrico dopo l’ordinanza sindacale dispositiva del TSO: note a margine della sentenza n. 76/2025
1. Che il diritto alla salute mentale integri una libertà (negativa e positiva) fondamentale riconosciuta dalla Costituzione non è res controversa a partire da numerosi interventi interpretativi della Corte costituzionale, che hanno esteso il concetto di salute anche a quella di natura psichica, connotando l’integrità fisica anche come sanità psicologica (v. sentt. Corte cost. n. 105/2001, 127/2022 e 212/2023, così come richiamate nel paragrafo 11.3 del “Ritenuto in fatto”).
Di particolare interesse è, pertanto, la sentenza in commento, che ha statuito l’importanza di sentire in contraddittorio il degente psichiatrico sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (di qui in poi: TSO), soggetto che – a causa dello stigma e del pregiudizio sociale sulla salute mentale, per essere sinteticamente obiettivi – veniva ritenuto inidoneo ad essere ascoltato dal giudice tutelare, seppur assistito da medici psichiatri, in quanto incapace di intendere e volere.
Dunque, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833/1978 (legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale), con una sentenza di accoglimento parziale, “nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente”; “nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»; “nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente››”.
In sintesi, ciò che viene censurato dal Giudice delle leggi è l’assenza di qualunque riferimento all’esigenza del contraddittorio anche nel procedimento di convalida dell’ordinanza sindacale dispositiva del TSO, cristallizzato com’è tale principio dall’art. 111 Cost.
Inquadrando la vicenda di merito che ha originato il giudizio incidentale, si sintetizza che il Sindaco ordinante aveva ingiunto alla ricorrente la necessità del trattamento sanitario obbligatorio in quanto, in primo luogo, la donna era pericolosa per la propria incolumità – avendo manifestato intenti suicidari – e, in seconda battuta, perché aveva rifiutato le cure psichiatriche.
In sede di impugnazione, in primo e secondo grado si era sostenuto e ribadito che i propositi suicidari della donna fossero stati dettati da un peggioramento clinico delle sue condizioni di salute legato ad un’assunzione eccessiva del farmaco “Tavor” (dettata, forse, dalla necessità spasmodica e disperata di arginare i pensieri tipici di una persona clinicamente depressa, traboccanti di sofferenza).
Così facendo, si è stigmatizzato in maniera rilevante l’accesso agli psicofarmaci, che rappresentano fonte di vita e sopravvivenza per gran parte dei malati psichiatrici, riducendo nettamente gli squilibri neuro-biochimici che possono condurre a quelle che, in un lessico ormai risalente e desueto, nonché improprio, sono le sintomatologie psicotiche, nevrotiche o depressive.
2. Il TSO si connota, ai sensi dell’art. 32, c. 2, Cost. (tuttavia, il riferimento è anche all’art. 13 Cost.), come una privazione “atipica” della libertà personale contro la volontà del paziente stesso, il quale viene sottoposto a trattamento obbligatorio in quanto pericoloso per l’incolumità propria e altrui.
Se, infatti, per la privazione “tipica” – data la concezione ormai pacifica in dottrina e giurisprudenza – della libertà personale (la detenzione “penalmente connotata”, anche nella forma domiciliare, oltre a quella penitenziaria), il principio della doppia riserva viene rispettato regolarmente, anche perché è quello il modello canonico di restrizione dell’art. 13 Cost. idealizzato dalla Costituente, nella procedura applicativa del TSO troviamo un passaggio ulteriore: l’emissione di un’ordinanza da parte del sindaco, di collocazione di certo non primaria nel rango delle fonti.
Sulla riserva di giurisdizione, nulla quaestio: il giudice tutelare convalida l’ordinanza sindacale entro quarantotto ore dalla sua emissione.
Sulla riserva di legge, che peraltro è antecedente logico-necessario della riserva di giurisdizione, si pongono più problematiche: sebbene gli articoli sottoposti a censura di costituzionalità (artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833/1978, la c.d. legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale), esplichino il principio di legalità previsto dall’art. 32, c. 2, Cost. nella parte in cui prevede che “nessuno può essere sottoposto a un determinato trattamento sanitario (ergo, obbligatorio) se non per disposizione di legge”, si avrebbe una sorta di degradazione del principio della riserva assoluta, poiché l’ordinanza sindacale, nel rango delle fonti, non è fonte primaria, bensì di carattere sub-legislativo.
Il trattamento sanitario obbligatorio, infatti, viene disposto discrezionalmente dal Sindaco sulla base di valutazioni extra-giuridiche, sociali e mediche: ciò implica, dunque, che si verifichi una “mediazione degradata” del principio di riserva di legge, tuttavia possibilmente legittimato sul principio di valutazioni “emergenziali” (sul punto si legga G. Azzariti, il quale, valutata come non conforme a Costituzione la prassi seguita dalle istituzioni italiane nella gestione della fase iniziale di espansione pandemica di SARS-CoV-2, si esprime per la non illegittimità degli atti adottati, affermando che nel caso di specie si sarebbe realizzata una «auto-assunzione di un potere extra-ordinem che si legittima per via di necessità»).
Trattando più diffusamente gli aspetti critici della sentenza che qui si commenta, si procede innanzitutto all’analisi dei parametri costituzionali invocati dal giudice a quo.
3. Come già anticipato nei paragrafi precedenti, la ricorrente era stata colpita da un provvedimento che aveva limitato la propria libertà personale mediante la forma dell’ordinanza sindacale dispositiva del trattamento sanitario obbligatorio, lamentando, in sede di primo e secondo grado di giudizio, l’assenza di qualsiasi cenno ad essere ascoltata in contraddittorio dal giudice tutelare, competente a convalidare il provvedimento sindacale.
Aveva, dunque, rilevato una minorazione al proprio diritto di difesa giudiziale (ed ecco perché è invocato, quale parametro, l’art. 24 Cost.).
È proprio sulla commistione dei diritti enucleati dagli artt. 24 e 32 Cost. che ci si soffermerà: tralasciando, quantomeno in una prima battuta, gli altri parametri, è opportuno ritenere di primario interesse – quale premessa – la concezione della capacità psichica del malato sottoposto a TSO in quanto essere senziente e sofferente.
Sugli altri articoli della Costituzione che vengono assunti quale parametro per la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla prima sezione civile della Corte di cassazione, v’è poco da dire: è chiaro che debbano essere riconosciuti, quali norme-parametro, anche gli articoli 2 e 3.
L’articolo 2 pare richiamato sia in virtù del principio personalistico del godimento del diritto alla salute, sia in virtù del principio solidaristico che si esplicherebbe nella necessità di ricevere cure adeguate.
L’articolo 3, d’altra parte, viene in rilievo soprattutto nella sua concezione sociale: il comma 2 rileverebbe più del comma 1 in quanto le cure ospedaliere garantite in sede di TSO devono riuscire a rendere effettivo e pregnante il principio di tutela della salute enucleato generalmente dall’art. 32 Cost.
Tuttavia, non si può negare come venga anche in rilievo il comma 1 per la non discriminazione su “condizioni personali e sociali”, dal momento che una malattia non può essere fonte di degradazione del principio di eguaglianza formale.
Viene chiamato in causa anche il comma 1 dell’art. 117 Cost. in quanto norma interposta con la disciplina della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolar modo con riferimento agli articoli 6 e 13: il fatto che siano richiamate queste due disposizioni, entrambe relative alla difesa processuale del giudicando (art. 6 CEDU: “Diritto a un equo processo”; art. 13 CEDU: “Diritto a un ricorso effettivo”), fa comprendere quanto la Corte costituzionale abbia voluto fare leva sull’aspetto giudiziale della questione, riconoscendo il pieno diritto di difesa in giudizio – che si esplica nell’equo contraddittorio tra le parti – anche a colui che (apparentemente?) è incapace di intendere e volere perché affetto da una grave forma di menomazione psichiatrica.
4. Dando per presupposto che il malato psichiatrico veniva ritenuto socialmente pericoloso (nel caso in questione, più per sé che per gli altri) sulla base di una presunzione iuris et de iure nell’ottica della legge n. 36/1904, si è assistito ad un grande processo di metamorfosi concettuale sul punto.
Infatti, la nota legge Basaglia (legge n. 180/1978) cambiò radicalmente il criterio di attribuzione dell’indice di pericolosità sociale in capo al malato psichico: se, infatti, prima lo si riteneva pericoloso in via di presunzione, il merito della legge sull’abolizione dei manicomi fu quello di considerarlo tale solo in caso concreto di commissione di un reato.
I criteri individuati dalla legge n. 180/1978 per identificare il TSO (che è comunque un’extrema ratio), sono triplici e seguono:
1) la sussistenza di una grave psicopatologia;
2) la riluttanza, se non proprio la recalcitranza assoluta ad accettare le cure;
3) l’impossibilità di accedere a misure extra-ospedaliere.
Di particolare rilievo, poi, il punto 11.3 del “Ritenuto in fatto”, in cui la Corte costituzionale riporta la considerazione del giudice a quo per cui vi sarebbe un parallelismo tra trattamento sanitario obbligatorio e privazione della libertà personale nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), nella parte in cui il giudice rimettente li richiama quali esempi di privazione “atipica” della libertà personale (perché “non connessi(a) a un procedimento penale”), poiché addirittura in quel caso il “ristretto” avrebbe diritto al contraddittorio e a essere ascoltato dal giudice con l’assistenza di un difensore (e di un interprete, come da garanzia del codice di procedura penale): viene richiamata la sentenza di questa stessa Corte n. 222/2004, che dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 5-bis, del d.lgs. 286/1998 (T.U. sull’immigrazione), così come interpolato dalla c.d. legge Bossi-Fini (legge n. 189/2002), nella parte in cui prevedeva che lo straniero potesse essere espulso dal territorio italiano senza che prima l’Autorità giudiziaria avesse potuto procedere ad una convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera – essendo questa una violazione manifesta del principio del contraddittorio e, dunque, del giusto processo.
5. Tuttavia, una questione appare rilevante ictu oculi: il fatto che la donna abbia (solo?) tentato il suicidio, senza riuscire all’atto pratico a darsi la morte (senza che nessuno abbia pensato al grado di sofferenza psichica che anche quest’esito, infausto agli occhi della malata, fausto agli occhi della società, abbia potuto comportare alla paziente la cui integrità psicologica è fortemente compromessa), risulterebbe, agli occhi della Magistratura, un viatico per stigmatizzare, ancora una volta, la condizione di sofferenza incompresa, sorda, che, troppo spesso, solo chi soffre a causa di menomazioni della salute mentale o ne è un professionista può comprendere.
Appare, alla luce delle considerazioni precedenti, estremamente svilente della condizione di integrità psico-fisica della paziente affermare che questa abbia tentato il suicidio per fare pressione sulle figlie, così come viene indicato nell’ordinanza di rimessione: sporgersi da un ponte per darsi la morte, nella speranza che ciò avvenga, non è già forse un po’ morire?
Questo principio di civiltà umana, prima ancora che giuridica, conduce a considerare che la materia della salute mentale risulta essere fortemente compromessa nell’impianto giuridico attuale, essendo stato l’art. 13 Cost. (e prima ancora, in epoca monarchica, l’art. 26 dello Statuto Albertino) elaborato principalmente sulla base del risalente habeas corpus, embrionalmente riconosciuto già nel Medioevo, nel 1215, nella Magna Charta Libertatum. Se è vero che questo principio nasceva come tutela alla fisicità dell’individuo dalle vessazioni corporali, le ormai notorie evidenze scientifiche conducono a sostenere l’inscindibilità di corpo e mente.
La Corte, in primo luogo, ha voluto concentrarsi sull’aspetto processuale e non di tutela sostanziale del diritto alla salute ex art. 32 Cost.: più che focalizzare la propria attenzione sul diritto fondamentale del malato psichico ad ottenere cure appropriate, si è concentrata sul rendere amplificata la voce del malato stesso, il quale – lo ha chiarito la Corte costituzionale – deve poter essere ascoltato dal giudice tutelare in sede giudiziale. E la sua voce deve poter essere ascoltata, clinicamente valutata dal filtro di un medico psichiatra che lo assista durante il contraddittorio.
6. Se è vero che, quindi, anche i più fragili hanno diritto al contraddittorio, ex artt. 24 e 111 Cost., per applicazione estensiva di quanto previsto dal codice di procedura penale per il “penalmente ristretto” e, in virtù di quanto appena detto, per lo straniero sottoposto a procedimento di espulsione finalizzata al rimpatrio, non sembra azzardato né tantomeno scorretto prevedere la stessa garanzia anche per il degente psichico.
Si tratta, ancora una volta, di un caso in cui la valutazione case by case sembra essere rilevante: seppur vero che non per tutti le psicopatologie sono gravi nella stessa maniera, è altrettanto vero che – in ossequio al principio di ragionevolezza – situazioni diverse, per poter essere eque, devono essere trattate in modo diverso.
Avevo letto che qualcuno s ...
A Lucca clamorosamente c� ...
Via Sercambi è diventata ...
Non solo un appello ...
Teoria e pratica. Dal 23 ...
È TEMPO DI CARNEVALFRAT ...
Circondata dall’affe ...
L accesso al pronto soccor ...
Il Coordinamento Nazionale ...
Se la sosta all ospedale S ...
Alessandro Salvini elett ...
Una due giorni, quella d ...
OVERTOURISM: RICERCA, 4 I ...
Ma possibile ? Sindaco , a ...
È incredibile come una co ...
Attenzione ai falsi SMS fi ...
PRIMO “FOCUS” SULLA M ...
Il Mar 10 Feb 2026, 08:47 ...
Al via i corsi brevi di ci ...
I discorsi a biscaro sciol ...
Da anni si ripete inascolt ...